Glifosato: nuove prove scientifiche confermano la sua cancerogenicità.
A cura della redazione
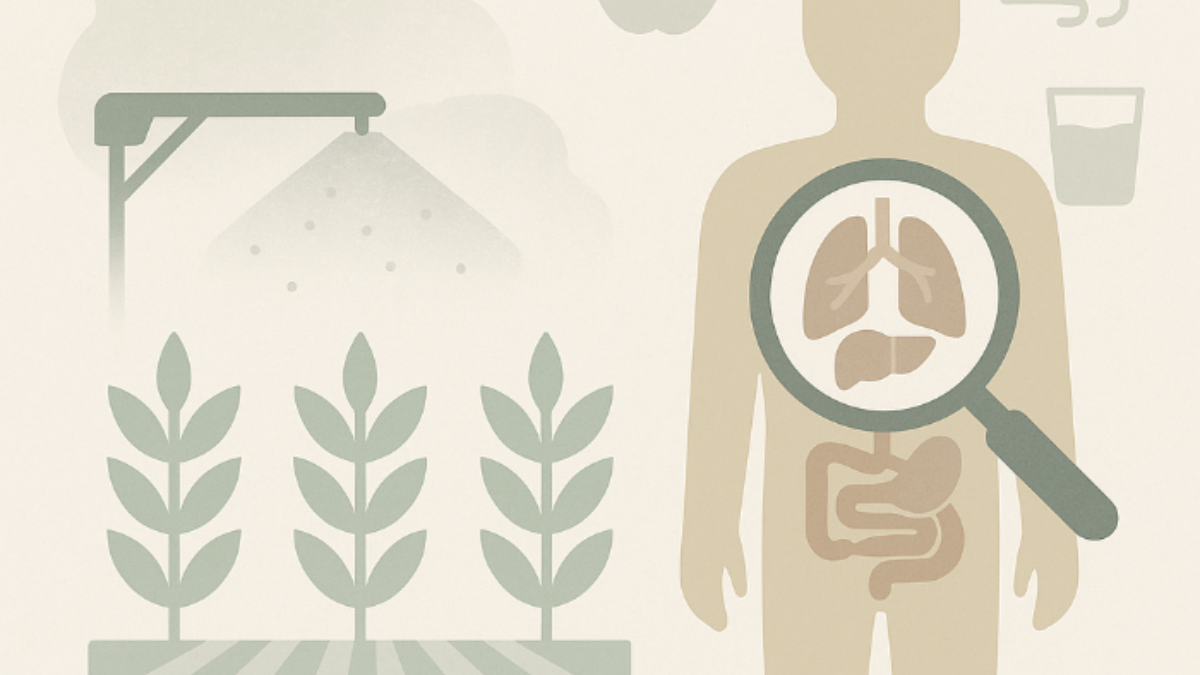
Un nuovo studio dell’Istituto Ramazzini conferma la cancerogenicità del glifosato, l’erbicida più usato al mondo. I risultati, pubblicati su Environmental Health, mostrano che anche a dosi considerate sicure, il glifosato causa tumori multipli nei ratti. La ricerca riaccende il dibattito sulla sua autorizzazione in Europa, rinnovata nel 2023 nonostante le crescenti evidenze scientifiche contrarie.
Cosa tratta:
Il glifosato, l’erbicida più utilizzato al mondo, è al centro di un nuovo e allarmante studio scientifico che ne conferma la pericolosità per la salute umana. A lanciare l’allerta è l’Istituto Ramazzini di Bologna, una delle più autorevoli realtà italiane nella ricerca indipendente, che ha pubblicato su Environmental Health i risultati del più ampio studio tossicologico mai condotto su questo composto chimico.Il Global Glyphosate Study (GGS), coordinato dalla dottoressa Fiorella Belpoggi e dal dottor Daniele Mandrioli, ha analizzato per oltre dieci anni gli effetti del glifosato e dei suoi erbicidi formulati (GBH) su ratti da laboratorio. I risultati sono inequivocabili: anche a dosi considerate “sicure” dalle autorità europee, il glifosato ha causato un aumento significativo di tumori benigni e maligni in più organi, tra cui fegato, tiroide, sistema nervoso, ovaie e tessuti emolinfopoietici.In particolare, è emersa una correlazione diretta tra l’esposizione a basse dosi di glifosato e l’insorgenza precoce di leucemie nei ratti, con decessi registrati già entro il primo anno di vita. Un dato che non trova riscontro nei controlli storici di riferimento, rendendo ancora più rilevante la scoperta.
Il glifosato è presente ovunque: nei cibi di uso quotidiano, nell’acqua piovana, nelle falde acquifere, nell’aria e persino nelle urine umane, comprese quelle di bambini e donne in gravidanza. È stato rilevato perfino nella Grande Barriera Corallina. Dal 1974, ne sono stati sparsi oltre 8,6 miliardi di chilogrammi nel mondo, con un’impennata del 1500% a partire dal 1996, anno dell’introduzione delle colture geneticamente modificate.
Una decisione europea che fa discutere
Nonostante le evidenze crescenti, nel 2023 la Commissione europea ha rinnovato per altri dieci anni l’autorizzazione all’uso del glifosato, seguendo il parere dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), che ha ritenuto non vi fossero prove sufficienti per vietarne l’uso. Una scelta che ha suscitato forti critiche da parte della comunità scientifica e delle organizzazioni ambientaliste. Tony Musu, ricercatore dell’Istituto Sindacale Europeo, ha ricordato che nel dicembre 2024 il network PAN Europe e altre ONG hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell’UE contro questa decisione, ritenuta in contrasto con il principio di precauzione sancito dalla normativa europea.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Monitorare l’uso di erbicidi: Verificare la presenza di glifosato nei prodotti utilizzati in azienda, anche indirettamente (es. manutenzione aree verdi).
- Valutare il rischio chimico: Integrare il glifosato (se in uso) tra le sostanze da considerare nella valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori.
- Formazione mirata: Informare i lavoratori sui rischi legati all’esposizione a erbicidi contenenti glifosato (se in uso).
- Sorveglianza sanitaria: Attivare programmi di controllo per i lavoratori potenzialmente esposti.
- Sostituzione del prodotto: Dove possibile, adottare alternative meno pericolose, in linea con il principio di precauzione.
- Aggiornamento continuo: Seguire l’evoluzione normativa e scientifica sul tema per adeguare tempestivamente le misure di prevenzione.
COSA DICE LA LEGGE
La normativa europea sui prodotti fitosanitari (Regolamento CE n. 1107/2009) vieta l’approvazione di sostanze attive classificate come cancerogene per l’uomo.
La classificazione dell’IARC del 2015, che definisce il glifosato come “probabile cancerogeno”, avrebbe dovuto attivare il principio di precauzione. Tuttavia, l’EFSA e l’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) hanno espresso valutazioni divergenti, sostenendo l’assenza di prove sufficienti. Questo ha permesso alla Commissione europea di rinnovare l’autorizzazione, nonostante le crescenti evidenze scientifiche contrarie.
Riproduzione riservata ©