Confrontare i numeri degli infortuni sul lavoro in Europa è quasi impossibile.
A cura della redazione
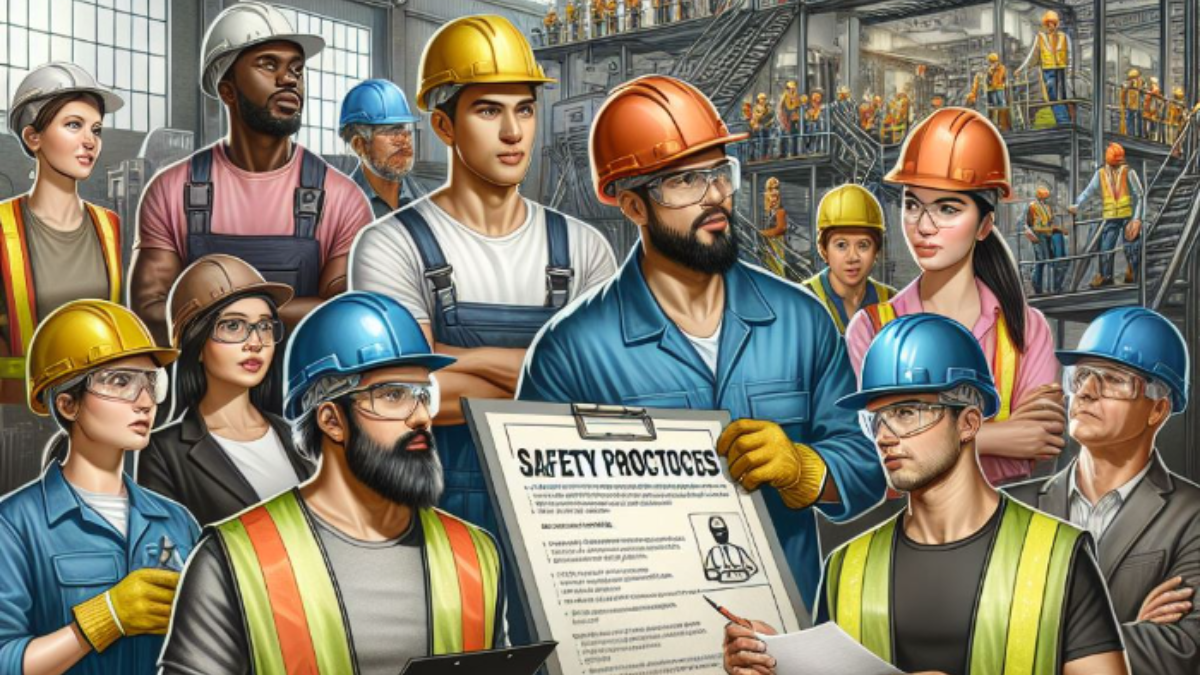
Confrontare i dati sugli infortuni sul lavoro tra i Paesi europei è un’impresa complessa. Le differenze nei sistemi di raccolta, nelle definizioni e nei modelli assicurativi rendono le statistiche poco comparabili. Il caso della Svizzera evidenzia come numeri elevati possano derivare da una maggiore trasparenza. Le norme UNI e ISO offrono strumenti più precisi per misurare il grado di sicurezza e il tasso di accadimenti. La formazione, grande assente nelle analisi, è invece uno strumento chiave per la prevenzione.
Cosa tratta:
Ogni giorno, in Europa, migliaia di lavoratori subiscono infortuni sul lavoro. Ma confrontare i dati tra i vari Paesi è tutt’altro che semplice. Le statistiche ufficiali, spesso citate nei media, nascondono dietro numeri apparentemente oggettivi una realtà molto più complessa, fatta di definizioni diverse, sistemi assicurativi disomogenei e culture della sicurezza profondamente differenti.
Numeri che non parlano la stessa lingua
Digitando “infortuni sul lavoro Italia” su un motore di ricerca si ottengono risultati contraddittori: “Italia tra i peggiori in Europa” oppure “In Italia si muore meno che altrove”. La verità è che i dati non sono omogenei. Eurostat, l’ente statistico europeo, raccoglie informazioni secondo criteri comuni, ma non tutti i Paesi li rispettano pienamente.
Ad esempio, in Germania non vengono conteggiate le morti avvenute oltre 30 giorni dall’incidente, anche se chiaramente collegate. In Italia, invece, l’INAIL include anche gli infortuni in itinere e quelli comunicati informalmente, persino tramite notizie stampa.
Come si misura un infortunio?
Secondo Eurostat, un infortunio è tale se comporta almeno quattro giorni interi di assenza dal lavoro. Non importa se si tratta di una distorsione o di una lesione permanente: tutto rientra nella stessa categoria. Le morti sul lavoro, invece, sono conteggiate solo se avvengono entro un anno dall’incidente e non includono eventi in itinere o causati da malori.
I parametri UNI e ISO: come si calcolano gli indici infortunistici
Le norme UNI 7249 e UNI ISO 45001 offrono strumenti più precisi per misurare e interpretare gli infortuni sul lavoro:
Indice di frequenza (UNI 7249):
IF=Numero di infortuni/Ore lavorate × 1.000.000
IF=Ore lavorate/Numero di infortuni × 1.000.000
Indica quanti infortuni si verificano ogni milione di ore lavorate.
Indice di gravità (UNI 7249):
IG=Giornate perse per infortuni/Ore lavorate × 1.000
IG=Ore lavorateGiornate perse per infortuni × 1.000
Misura l’impatto degli infortuni in termini di giorni persi.
UNI ISO 45001:
Non si limita al conteggio, ma impone un sistema di gestione integrato che include:
- Analisi dei mancati infortuni.
- Coinvolgimento attivo dei lavoratori.
- Leadership e cultura della sicurezza.
- Monitoraggio continuo delle prestazioni.
- Miglioramento continuo e gestione del rischio.
Questi parametri permettono di andare oltre il semplice conteggio e di valutare l’efficacia delle politiche di prevenzione.
Il caso Svizzeraiù infortuni, ma anche più trasparenza
La Svizzera risulta tra i Paesi con il più alto numero di infortuni. Ma è davvero meno sicura? Non proprio. Il sistema assicurativo elvetico garantisce indennizzi generosi, incentivando la denuncia. Inoltre, tutti i lavoratori sono obbligatoriamente assicurati, anche per infortuni extra-lavorativi. Questo porta a una maggiore tracciabilità, ma anche a numeri più alti.
Uno studio svizzero ha dimostrato che, ricalcolando i dati con parametri più realistici, la posizione del Paese migliora sensibilmente. Al contrario, Paesi come Bulgaria e Romania, dove gli indennizzi sono minimi e l’economia sommersa è elevata, mostrano tassi bassi che probabilmente nascondono una forte sottodenuncia.
Il ruolo della formazione: grande assente nelle statistiche
Sorprendentemente, la formazione non è considerata nei parametri di analisi. Eppure, è uno degli strumenti più efficaci per prevenire gli infortuni. Il Regno Unito ha introdotto il concetto di “Leadership in materia di sicurezza”, mentre la Germania ha puntato sulla condivisione delle responsabilità. In Italia, invece, la formazione è spesso vissuta come un obbligo burocratico, senza una reale ricaduta pratica.
La pandemia ha costretto a ripensare i modelli formativi, introducendo corsi a distanza e nuovi contenuti. Ma serve di più: coinvolgere i lavoratori, renderli protagonisti della sicurezza, far sì che percepiscano il rischio come parte della quotidianità e non come un concetto astratto.
Conclusione: oltre i numeri, verso una cultura della sicurezza
I dati sono importanti, ma non bastano. Serve una lettura critica, contestualizzata, che tenga conto delle differenze normative, culturali e sociali. E serve una formazione efficace, continua, partecipata. Solo così si potrà davvero ridurre il numero degli infortuni e costruire una cultura della sicurezza condivisa in tutta Europa.
COSA DICE LA LEGGE
- Regolamento (CE) n. 1338/2008: stabilisce le modalità di raccolta delle statistiche europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Regolamento (UE) n. 349/2011: attua le disposizioni del regolamento 1338/2008.
- UNI 7249: definisce gli indici di frequenza e gravità degli infortuni.
- UNI ISO 45001: sistema di gestione certificabile per la salute e sicurezza sul lavoro, con focus su leadership, coinvolgimento, miglioramento continuo.
- DL 18/2020 (Italia): riconosce le infezioni da Covid-19 come infortuni sul lavoro.
- Sistema INAIL: raccoglie dati anche da fonti informali e aggiorna le statistiche con cadenza semestrale e mensile.
INDICAZIONI OPERATIVE
Per RSPP e HSE Manager
- Analizzare criticamente i dati, considerando definizioni e criteri di raccolta.
- Integrare i dati INAIL con quelli Eurostat e UNI.
- Monitorare i settori ad alto rischio.
- Applicare gli indici UNI 7249 per valutare frequenza e gravità.
- Implementare un sistema di gestione secondo UNI ISO 45001.
- Promuovere la formazione attiva e partecipata.
- Valutare l’efficacia della formazione in termini pratici.
- Favorire la denuncia degli infortuni.
- Contestualizzare i dati post-pandemia.
- Utilizzare strumenti digitali per la raccolta e l’analisi dei dati.
Riproduzione riservata ©