Ripensare la sicurezza comportamentale: dalla punizione alla cultura del dialogo
A cura della redazione
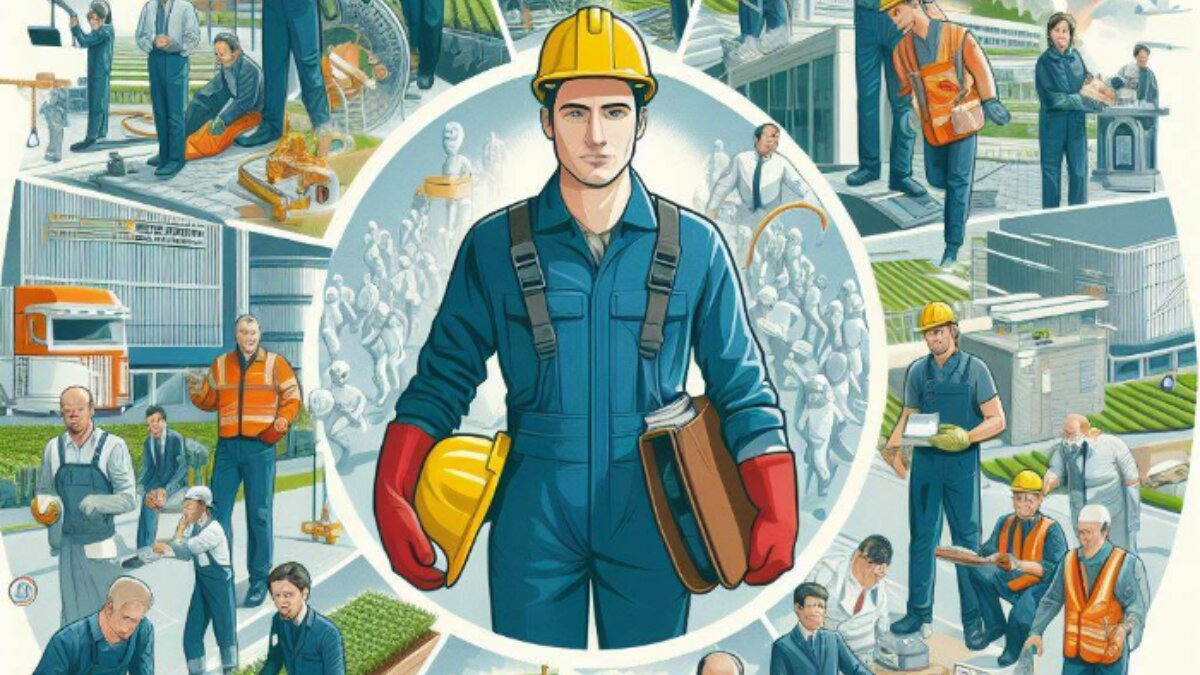
La sicurezza comportamentale, spesso fraintesa e mal applicata, può diventare uno strumento potente per migliorare la cultura aziendale in materia di SSL. E’ possibile proporre un approccio rinnovato, centrato sulle persone, sulla fiducia e sull’uso intelligente dei dati, offrendo spunti pratici per RSPP e HSE manager.
Cosa tratta :
La sicurezza comportamentale (ad esempio la Behavior-Based Safety, BBS, ma non solo) è da anni al centro del dibattito tra professionisti della salute e sicurezza sul lavoro. Se da un lato molte organizzazioni continuano a investire in programmi di sicurezza comportamentale, dall’altro cresce il numero di esperti che ne denunciano i limiti e le distorsioni di applicazione.
Ma cosa è andato storto? E come possiamo ripensare questo approccio per renderlo davvero efficace? Molti programmi di sicurezza comportamentale, si sono più o meno lentamente trasformati in strumenti punitivi, focalizzati sull’osservazione e correzione dei comportamenti “sbagliati”.
Il risultato? Un clima di sfiducia, ansia e resistenza da parte dei lavoratori, anche nei confronti dei colleghi osservatori. Le checklist diventano un fine, non un mezzo, e il dialogo si riduce a un elenco di rimproveri. Ma sono decenni che stiamo dicendo che la sicurezza non si costruisce con la paura. Il comportamento umano è il risultato di una rete complessa di motivazioni, pressioni e contesti. Non possiamo cambiarlo senza comprenderlo.
La svolta: mettere al centro le persone
Per costruire una cultura aziendale della sicurezza solida, serve un cambio di paradigma. Non più regole imposte dall’alto, ma il coinvolgimento più attivo dei lavoratori. I leader devono essere presenti, ascoltare, dimostrare interesse autentico per il benessere delle persone.
È il principio della “Servant Leadership”: chiedere “come posso aiutarti?” anziché “perché hai sbagliato?”
La fiducia è la chiave. Solo in un ambiente psicologicamente sicuro i lavoratori si sentiranno liberi di segnalare problemi, proporre soluzioni e assumersi responsabilità.
Errori e violazioni: distinguere per prevenire
Non tutti i comportamenti insicuri sono uguali. Alcuni sono errori involontari, legati a distrazione, stanchezza o carenze formative. Altri sono violazioni consapevoli, spesso dettate da pressioni produttive o da una cultura aziendale che premia la velocità più della sicurezza. Capire questa distinzione è fondamentale per intervenire in modo mirato, evitando punizioni inutili e promuovendo soluzioni strutturali.
Dai numeri alle persone: usare i dati in modo intelligente
Molti programmi di sicurezza comportamentale, si limitano a contare osservazioni e incidenti. Ma i dati e soprattutto indicatori mirati, possono fare molto di più. Grazie all’analisi predittiva, è possibile individuare i fattori di rischio prima che si traducano in incidenti. Non basta sapere “cosa è successo”: bisogna capire “perché” e “come evitarlo”. Le organizzazioni più evolute stanno passando da una logica reattiva a una proattiva, dove la sicurezza è misurata non solo ed esclusivamente dall’assenza di incidenti, ma dalla capacità di anticipare e gestire i rischi, cercando di comprendere persone e comportamenti prima che si registrino eventi.
Secondo esperti del settore, il controllo non è più e non solo una funzione tecnica, ma un presidio culturale. Nell’ ottica dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, le organizzazioni devono formare i propri preposti come “sentinelle attive”, capaci di cogliere i segnali deboli e tradurli in azioni concrete.
La sicurezza non è un adempimento, ma un processo continuo che coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione.
COSA DICE LA LEGGE
La normativa italiana sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) non menziona esplicitamente la “sicurezza comportamentale”, ma ne riconosce i principi fondamentali:
- Art. 15: tra le misure generali di tutela, include la formazione, l’informazione e la partecipazione dei lavoratori.
- Art. 18: impone al datore di lavoro di promuovere comportamenti sicuri e di vigilare sul rispetto delle norme.
- Art. 19: attribuisce ai preposti il compito di sorvegliare e correggere i comportamenti non conformi.
Inoltre, il sistema premiale previsto dal D.Lgs. 231/2001 può incentivare l’adozione di modelli organizzativi che includano programmi si sicurezza comportamentale efficaci e non punitivi.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Analizza il contesto: prima di correggere un comportamento, indaga le cause ambientali, organizzative e personali.
- Coinvolgi i lavoratori: crea momenti di confronto e ascolto attivo, valorizzando le esperienze sul campo.
- Promuovi la leadership partecipativa: forma i dirigenti a uno stile di guida basato sulla fiducia e sul supporto.
- Distinguere errori da violazioni: adotta strumenti di analisi che permettano di capire la natura del comportamento.
- Usa i dati in modo predittivo: integra le osservazioni con indicatori di performance e analisi dei near miss.
- Favorisci la trasparenza: elimina le logiche punitive legate agli incidenti e incentiva la segnalazione volontaria.
- Misura la cultura: utilizza survey e interviste per valutare atteggiamenti, percezioni e clima aziendale.
- Forma con esempi positivi: mostra cosa funziona e perché, non solo cosa è andato storto.
- Integra la sicurezza comportamentale nel sistema 45001 e di conseguenza anche in quello 231: valorizza il comportamento sicuro come parte del modello organizzativo "efficacemente attuato".
- Monitora e adatta: verifica periodicamente l’efficacia del programma e apporta modifiche basate sui feedback.
Riproduzione riservata ©